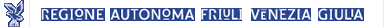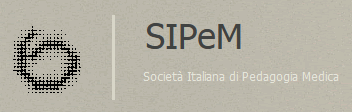Dettaglio Attività Formativa
Dettaglio Attività Formativa
- Legenda
- Formazione:
 "RES": Residenziale
"RES": Residenziale "FSC": Formazione Sul Campo
"FSC": Formazione Sul Campo "FAD": Formazione a Distanza
"FAD": Formazione a Distanza
- Edizione:
 annullata
annullata sospesa
sospesa già svolta
già svolta in corso di svolgimento
in corso di svolgimento in programma
in programma
Crediti assegnati: 20 Durata: 17:30 ore
Tipo attività formativa: Formazione Residenziale
Tipologia: Corso di formazione e/o applicazione di percorsi assistenziali e diagnostico-terapeutici (con indicazione di una parte pratica)
Tipologia: Corso di formazione e/o applicazione di percorsi assistenziali e diagnostico-terapeutici (con indicazione di una parte pratica)
Organizzato da:
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 - Medio Friuli (Udine)
+ elenco edizioni - Nascondi elenco edizioni
>> professioni partecipanti
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 - Medio Friuli (Udine)
+ elenco edizioni - Nascondi elenco edizioni
>> professioni partecipanti
Quote di iscrizione: Minimo 0,00 € Massimo 100,00 €
Segreteria organizzativa
Referente: Tamara Boschi
Telefono: 3356180387 Fax: 0432553310
E-mail: tamara.boschi@ass4.sanita.fvg.it
Telefono: 3356180387 Fax: 0432553310
E-mail: tamara.boschi@ass4.sanita.fvg.it
Informazioni sull'attività formativa
Responsabili Scientifici: BIASUTTI EMANUELE, CARLOMAGNO SERGIO, DI BENEDETTO PAOLO
Breve descrizione dell'attività formativa residenziale nel suo complesso
Questo corso si connota come azione attuativa del Piano Regionale della Riabilitazione in quanto risponde ad uno degli obiettivi individuati per l'ospedale Gervasutta,ovvero la realizzazione di una risposta diagnostico-terapeutica alla domanda relativa ai disturbi neuropsicologici dell'età adulta Si prefigge principalmente l'obiettivo di fornire le nozioni di base di neuropsicologia dei soggetti con cerebrolesione acquisita e vuole inoltre riportare l'attenzione su alcune implicazioni di diagnosi e riabilitazione neuropsicologica utili agli operatori sanitari. E' indirizzato prevalentemente a logopedisti , fisioterapisti e ad un ristretto numero di medici e psicologi che ritengano opportuno acquisire una formazione di base sui principali disturbi neuropsicologici che si riscontrano nei soggetti con cerebrolesione acquisita.Per perseguire questo scopoprevalentemente formativo, il corso è stato suddiviso in 4 moduli: disturbi della comunicazione, il controllo del movimento e le aprassie, le capacità attentive e funzioni di controllo esercitato dalle strutture frontali, la memoria el anefgligenza spaziale unilaterale. In ognuno dei moduli si forniranno elementi utili ad una conoscenza di base dell'argomento trattato. Essendo il corpus di conoscenze sl funzionamento del cervello tipicamente multidisciplinare si tenterà di esplicitare questo concetto attraverso l'organizzazione degli interventi dei relatori all'interno dei moduli. Infatti ognuno di questi prevede una stratificazione di argomenti provenienti da diverse discipline:le neuroscienze, la neuropsicologia, la riabilitazione neurologica e neuropsicologica. Attraverso questa impostazione non si vuole certo avere la pretesa di essere esaustivi su tutti gli argomenti trattai, peraltro per molti aspetti non ancora conosciuti, piuttosto si tenterà di fornire degli esempi di conoscenza del Sistema Nervoso e della sua patologia derivante da un approccio multidisciplinare. Contemporaneamente, la trattazione dello stesso
Breve descrizione delle relazioni più significative
Negligenza Spaziale Unilaterale: classificazione e modelli neuropsicologici Autore: Dott.ssa Federica Mondolo La Negligenza Spaziale Unilaterale (NSU) è un disturbo dell'attenzione selettiva spaziale che si presenta solitamente in seguito a lesioni del lobulo parietale inferiore destro. Il paziente con grave NSU si comporta come se non fosse più in grado di percepire e concepire l'esistenza del lato sinistro dello spazio personale, peripersonale ed extrapersonale. Le interpretazioni del NSU sono state essenzialmente tre. La prima ipotesi, quella sensoriale-percettiva, interpreta la NSU come un deficit dell'integrazione delle informazioni sensoriali e sensitive provenienti dallo spazio corporeo ed extracorporeo a cui è deputato il lobo parietale destro. La seconda interpretazione è quella di Bisiach (1978) il quale attribuisce la NSU ad un'alterata rappresentazione interna dello spazio. L'interpretazione più accreditata della NSU è quella attenzionale, secondo la quale i pazienti pur avendo i meccanismi sensoriali e percettivi relativamente conservati, avrebbero una tendenza ad orientare l'attenzione verso lo spazio ipsilaterale alla lesione ed una difficoltà a spostarla verso lo spazio controlaterale, che viene ignorato. I disturbi attenzionali della NSU possono essere spiegati considerando il modello interpretativo di Kinsbourne (1993) che attribuisce all'emisfero destro un ruolo preponderante nell'orientamento dell'attenzione. Disturbi della comunicazione: cenni di neuroscienze Autore: Dott.ssa Federica Mondolo Solo a partire dal XIX secolo è emersa una chiara relazione tra cervello e linguaggio basata sull'osservazione anatomo-clinica, in cui le alterazioni del comportamento verbale registrate al momento dell'osservazione clinica del soggetto afasico venivano correlate al danno cerebrale riscontrato dopo la morte del paziente all'esame autoptico. Sulla base di tale metodo prima Broca (1861) e poi Wernicke (1874) scoprirono rispettivamente le aree cerebrali responsabili della produzione e della comprensione del linguaggio, che ancora oggi portano i loro nomi. I meriti di questi ricercatori e le conoscenze che si sono accumulate a partire dai loro lavori sono notevoli e indiscutibili ma il metodo d'indagine da essi utilizzato presentava importanti limiti, come evidenziato dagli studi degli ultimi venti anni della neuropsicologia sperimentale. Attualmente sono principalmente le neuroscienze a studiare i processi cerebrali che sottendono la formazione del linguaggio con un approccio interdisciplinare che coinvolge molti livelli da quello molecolare ai grandi sistemi come la corteccia cerebrale. Le neuroscienze si sono sviluppate anche grazie all'avvento delle nuove tecnologie di neuroimmagine per cui è stato possibile stabilire in vivo, con precisione sempre maggiore, la sede e l'estensione delle lesioni. Inoltre, le metodiche di tipo funzionale, che consentono di indagare direttamente il flusso ematico e il metabolismo regionali del cervello, in soggetti afasici e normali, hanno consentito di definire con notevole accuratezza le aree coinvolte durante l'esecuzione di compiti linguistici. L'insieme delle evidenze raccolte negli ultimi anni ha mostrato come il ruolo delle aree di Wernicke e di Broca non è così netto come sembrava e che l'elaborazione del linguaggio richiede l'interazione di un'ampia rete di aree cerebrali. Capacità attentive e funzioni di controllo esercitate dalle strutture frontali. Autore: Dott.ssa Alessia Granà Nell'uomo e nei primati non umani i lobi frontali partecipano alla regolazione di numerosi aspetti del comportamento adattivo all'ambiente e, in generale, al controllo dei processi cognitivi superiori che operano nelle situazioni quotidiane complesse e in contesti non abituali. Tali processi cognitivi sono definiti "funzioni esecutive"; essi svolgono infatti compiti di supervisione, di elaborazione e di coordinazione di tutte le funzioni cere
Questo corso si connota come azione attuativa del Piano Regionale della Riabilitazione in quanto risponde ad uno degli obiettivi individuati per l'ospedale Gervasutta,ovvero la realizzazione di una risposta diagnostico-terapeutica alla domanda relativa ai disturbi neuropsicologici dell'età adulta Si prefigge principalmente l'obiettivo di fornire le nozioni di base di neuropsicologia dei soggetti con cerebrolesione acquisita e vuole inoltre riportare l'attenzione su alcune implicazioni di diagnosi e riabilitazione neuropsicologica utili agli operatori sanitari. E' indirizzato prevalentemente a logopedisti , fisioterapisti e ad un ristretto numero di medici e psicologi che ritengano opportuno acquisire una formazione di base sui principali disturbi neuropsicologici che si riscontrano nei soggetti con cerebrolesione acquisita.Per perseguire questo scopoprevalentemente formativo, il corso è stato suddiviso in 4 moduli: disturbi della comunicazione, il controllo del movimento e le aprassie, le capacità attentive e funzioni di controllo esercitato dalle strutture frontali, la memoria el anefgligenza spaziale unilaterale. In ognuno dei moduli si forniranno elementi utili ad una conoscenza di base dell'argomento trattato. Essendo il corpus di conoscenze sl funzionamento del cervello tipicamente multidisciplinare si tenterà di esplicitare questo concetto attraverso l'organizzazione degli interventi dei relatori all'interno dei moduli. Infatti ognuno di questi prevede una stratificazione di argomenti provenienti da diverse discipline:le neuroscienze, la neuropsicologia, la riabilitazione neurologica e neuropsicologica. Attraverso questa impostazione non si vuole certo avere la pretesa di essere esaustivi su tutti gli argomenti trattai, peraltro per molti aspetti non ancora conosciuti, piuttosto si tenterà di fornire degli esempi di conoscenza del Sistema Nervoso e della sua patologia derivante da un approccio multidisciplinare. Contemporaneamente, la trattazione dello stesso
Breve descrizione delle relazioni più significative
Negligenza Spaziale Unilaterale: classificazione e modelli neuropsicologici Autore: Dott.ssa Federica Mondolo La Negligenza Spaziale Unilaterale (NSU) è un disturbo dell'attenzione selettiva spaziale che si presenta solitamente in seguito a lesioni del lobulo parietale inferiore destro. Il paziente con grave NSU si comporta come se non fosse più in grado di percepire e concepire l'esistenza del lato sinistro dello spazio personale, peripersonale ed extrapersonale. Le interpretazioni del NSU sono state essenzialmente tre. La prima ipotesi, quella sensoriale-percettiva, interpreta la NSU come un deficit dell'integrazione delle informazioni sensoriali e sensitive provenienti dallo spazio corporeo ed extracorporeo a cui è deputato il lobo parietale destro. La seconda interpretazione è quella di Bisiach (1978) il quale attribuisce la NSU ad un'alterata rappresentazione interna dello spazio. L'interpretazione più accreditata della NSU è quella attenzionale, secondo la quale i pazienti pur avendo i meccanismi sensoriali e percettivi relativamente conservati, avrebbero una tendenza ad orientare l'attenzione verso lo spazio ipsilaterale alla lesione ed una difficoltà a spostarla verso lo spazio controlaterale, che viene ignorato. I disturbi attenzionali della NSU possono essere spiegati considerando il modello interpretativo di Kinsbourne (1993) che attribuisce all'emisfero destro un ruolo preponderante nell'orientamento dell'attenzione. Disturbi della comunicazione: cenni di neuroscienze Autore: Dott.ssa Federica Mondolo Solo a partire dal XIX secolo è emersa una chiara relazione tra cervello e linguaggio basata sull'osservazione anatomo-clinica, in cui le alterazioni del comportamento verbale registrate al momento dell'osservazione clinica del soggetto afasico venivano correlate al danno cerebrale riscontrato dopo la morte del paziente all'esame autoptico. Sulla base di tale metodo prima Broca (1861) e poi Wernicke (1874) scoprirono rispettivamente le aree cerebrali responsabili della produzione e della comprensione del linguaggio, che ancora oggi portano i loro nomi. I meriti di questi ricercatori e le conoscenze che si sono accumulate a partire dai loro lavori sono notevoli e indiscutibili ma il metodo d'indagine da essi utilizzato presentava importanti limiti, come evidenziato dagli studi degli ultimi venti anni della neuropsicologia sperimentale. Attualmente sono principalmente le neuroscienze a studiare i processi cerebrali che sottendono la formazione del linguaggio con un approccio interdisciplinare che coinvolge molti livelli da quello molecolare ai grandi sistemi come la corteccia cerebrale. Le neuroscienze si sono sviluppate anche grazie all'avvento delle nuove tecnologie di neuroimmagine per cui è stato possibile stabilire in vivo, con precisione sempre maggiore, la sede e l'estensione delle lesioni. Inoltre, le metodiche di tipo funzionale, che consentono di indagare direttamente il flusso ematico e il metabolismo regionali del cervello, in soggetti afasici e normali, hanno consentito di definire con notevole accuratezza le aree coinvolte durante l'esecuzione di compiti linguistici. L'insieme delle evidenze raccolte negli ultimi anni ha mostrato come il ruolo delle aree di Wernicke e di Broca non è così netto come sembrava e che l'elaborazione del linguaggio richiede l'interazione di un'ampia rete di aree cerebrali. Capacità attentive e funzioni di controllo esercitate dalle strutture frontali. Autore: Dott.ssa Alessia Granà Nell'uomo e nei primati non umani i lobi frontali partecipano alla regolazione di numerosi aspetti del comportamento adattivo all'ambiente e, in generale, al controllo dei processi cognitivi superiori che operano nelle situazioni quotidiane complesse e in contesti non abituali. Tali processi cognitivi sono definiti "funzioni esecutive"; essi svolgono infatti compiti di supervisione, di elaborazione e di coordinazione di tutte le funzioni cere
Lingua: Italiano
Professioni partecipanti
Medico chirurgo - Area interdisciplinare
Psicologo - Area interdisciplinare
Fisioterapista
Infermiere
Logopedista
Psicologo - Area interdisciplinare
Fisioterapista
Infermiere
Logopedista
Docenti torna su
BARBALARGA SANDRA, BIASUTTI EMANUELE, BOSCHI TAMARA, CARLOMAGNO SERGIO, COSTANTINI ELENA, DEL TIN SILVANA, DEPANGHER LUCIA, FABBRO FRANCO, FABBRO NERINA, GRANA' ALESSIA, LINDAVER PAOLO, MARIN DARIO, MONDOLO FEDERICA, MOSANGHINI RENZO, PLAINO MARIA, SALVADORI CAVAZZON MONICA, VOLTAZZA ANNA, VORANO LORENZA
Obiettivo Formativo
Promozione della cultura riabilitativa, sviluppo delle competenze professionali per l'acquisizione di metodologie di cura mirate e definizione di protocolli specifici per patologie.
Appartenente agli Obiettivi Nazionali
Appartenente agli Obiettivi Nazionali
Materiale didattico
Dispensa preparata dal docente
Indicazioni bibliografiche
Stampe/CD delle slide/diapositive presentate
Indicazioni bibliografiche
Stampe/CD delle slide/diapositive presentate
Verifica dell'apprendimento
Questionario
Confronto tra risultati del test di ingresso/test finale
Confronto tra risultati del test di ingresso/test finale